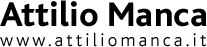di Matilde Geraci
Presentato a Palermo il libro-inchiesta di Luciano Mirone, che affronta il “suicidio” di mafia dell’urologo barcellonese. Di seguito, il racconto dell’evento
Vittima sacrificale da offrire sull’altare della mafia, per dimostrare che Barcellona Pozzo di Gotto poteva essere per Messina quello che Corleone era stata per Palermo. È questo, il destino in cui si imbatté l’urologo siciliano Attilio Manca, la cui morte è legata a doppio filo alla latitanza di Bernardo Provenzano e in particolare all’intervento chirurgico a cui si sottopose il boss nell’ottobre 2003 a Marsiglia. Il più potente dei capi di Cosa nostra poteva essere operato soltanto dal migliore degli specialisti e fu così che il giovane medico gli fu servito su un piatto d’argento. Poi, una volta divenuto testimone scomodo che aveva visto il volto della mafia e di quella parte di Stato che con la mafia va a braccetto, è stato eliminato. Nessun suicidio, figuriamoci un’overdose. Eppure c’è una Procura, quella di Viterbo, che porta avanti questa tesi con un’ostinazione e un’arroganza smaccatamente esibite. Troppe cose non tornano in questa vicenda avvolta da un mistero lungo dieci anni, da quella tragica notte a cavallo tra l’11 e il 12 febbraio 2004. Quarant’anni prima, e in merito ad altre questioni, Pasolini scriveva: «Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi». Quelle parole ritornano alla mente, pensando alla fine che hanno fatto fare ad Attilio, ma con un’unica differenza: anche noi sappiamo e non abbiamo le prove. Ma gli indizi, almeno quelli, ce ne sono tantissimi.
Uno per uno vengono raccontati e analizzati nel libro-inchiesta del giornalista e scrittore Luciano Mirone, intitolato Un “suicidio” di mafia. La strana morte di Attilio Manca (ed. Castelvecchi, 2014) e presentato ieri nell’aula consiliare di Palazzo delle Aquile di Palermo. Con penna esperta, l’autore scava all’interno della storia incredibilmente vera e conduce il lettore a Barcellona Pozzo di Gotto, lì dove è maturato quello che a tutti gli effetti appare come un omicidio. «Per chi non lo sapesse – afferma Mirone – è un ambiente estremamente pericoloso, dove esiste un circolo chiamato “Corda Fratres” strettamente legato al boss Giuseppe Gullotti, ritenuto il mandante del delitto del giornalista Beppe Alfano, e un altro boss (oggi al 416 bis), Rosario Pio Cattafi, molto vicino ai Servizi segreti deviati nonché in un primo momento ritenuto uno dei mandanti esterni della strage di Capaci. Queste persone vanno a braccetto con l’ex procuratore generale della Repubblica di Messina Antonio Franco Cassata, con l’ex vicepresidente del Senato Domenico Nania e con suo cugino, l’ex sindaco di Barcellona Candeloro Nania, e con l’ex presidente della Provincia di Messina Giuseppe Buzzanca. Non si tratta certo di un’iscrizione al circolo fatta distrattamente da questi personaggi – sottolinea lo scrittore – È acclarato, per esempio, che il boss Cattafi è molto intimo dell’ex procuratore di Messina Cassata. Giuseppe Gullotti faceva parte delle liste del Movimento Sociale Italiano quando, Beppe Alfano, che faceva parte dello stesso partito, rivolse il suo grido di dolore persino all’allora leader della Destra italiana Giorgio Almirante. Il giornalista gli disse: “Segretario, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Msi, Nania e i suoi compari hanno candidato Gullotti”. Almirante alzò le spalle e gli rispose: “Mio piccolo Goria (per la somiglianza tra Alfano e l’ex presidente del Consiglio Giovanni Goria, Ndr), non posso farci nulla”. E se lo dice il capo della Destra italiana, vuol dire evidentemente che questi legami fra mafia e politica a Barcellona, in epoca non sospetta, erano già molto forti». Non solo. A Barcellona è stato costruito il telecomando per la strage che ha fatto a pezzi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Circostanza che indica il forte legame tra i Barcellonesi e i Corleonesi. «Ciò vuol dire che un pezzo importante della mente eversiva di quel periodo della strategia della tensione risiede a Barcellona Pozzo di Gotto». Durante la stesura del libro, Luciano Mirone conosce casualmente ad un convegno un investigatore dell’epoca in cui Attilio viene trovato morto e Provenzano si godeva la propria latitanza all’interno di un convento di Barcellona Pozzo di Gotto. «Questa persona, autorevole e affidabile, mi dice esattamente che Attilio Manca venne prelevato in elicottero e portato nella zona di Tonnarella, in una struttura privata che qualche medico locale mise a disposizione, e lì visitò Provenzano. Secondo la testimonianza di questa persona, avvenne prima dell’intervento di Marsiglia, quando cioè si doveva fare la diagnosi. L’ex investigatore va oltre, dicendomi che quando muore Attilio Manca, il Ros fa delle indagini e scopre che possono esserci dei collegamenti tra la morte di Attilio e la latitanza del boss mafioso a Barcellona. Ad un certo punto arriva un diktat dall’alto: “Prego trasmettere immediatamente atti relativi alla morte di Attilio Manca e alla latitanza di Bernardo Provenzano”. Una richiesta che può voler dire soltanto una cosa: o chiedono gli atti per depistare, oppure perché si vuole fare giustizia. Due giorni dopo, non avendo ancora ricevuto nulla dal Ros, questo personaggio molto in alto scrive nuovamente per ricevere gli atti “senza ulteriori indugi”. E senza ulteriori indugi questi atti vengono trasmessi. Da quel momento le indagini sia sulla morte di Attilio che sulla latitanza di Provenzano a Barcellona si sono arenate». Al cospetto di questi e altri fatti riportati nel libro, sarebbe doveroso da parte dell’autorità giudiziaria quantomeno fare un riscontro, verificare se esistono queste carte, approfondire per esempio il periodo in cui Provenzano è stato a Barcellona Pozzo di Gotto, vedere di quale medico siciliano parlava il braccio destro del boss Francesco Pastoia dal carcere di Modena poco prima di morire anche lui in circostanza misteriose. «Dopo alcuni mesi dalla morte di Attilio Manca, Pastoia viene intercettato dalle ambientali e dice una cosa precisa in un contesto molto significativo. Ovvero, mentre sta parlando degli omicidi commessi da Provenzano, afferma che questi è stato visitato da un urologo siciliano. Siccome l’unico urologo siciliano in quel periodo ad operare di cancro alla prostata per laparoscopia era Manca, due più due fa quattro». Perché non è stato approfondito questo aspetto? Perché, se non si tratta di Attilio, non si è tentato di chiarire chi fosse quel medico siciliano?
Troppe, sono le verità ancora inesplorate. «Bisogna partire dalla permanenza di Attilio Manca in Francia», afferma il giornalista de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Lo Bianco, anche lui presente all’evento. «C’è un magistrato, Michele Prestipino, che dichiara di aver scandagliato minuto per minuto tutti i movimenti e tutte le persone che hanno accompagnato Provenzano in Francia, i medici che lo hanno operato e le persone che lo hanno assistito anche nel suo ritorno in Sicilia. Nulla è emerso, stando sempre a quanto affermato da Prestipino, che possa essere ricondotto ad Attilio Manca. La domanda che io, però, mi faccio da cronista è se è stato cercato qualcosa che faccia riferimento al Manca, o ci si è accontentati soltanto di un’indagine mirata esclusivamente ad approfondire gli aspetti del favoreggiamento della latitanza di Bernardo Provenzano?». Non c’è poi bisogno di andare tanto lontano per capire che siamo immersi in una storia di depistaggi. «Ho rivisto quest’oggi la conferenza stampa del procuratore capo di Viterbo Alberto Pazienti e del pm Renzo Petroselli, in cui portano avanti con determinazione, nemmeno la tesi del suicidio, ma quella della morte per droga, perché danno per assunto che Attilio Manca fosse un tossicodipendente. La conferenza è un crescendo di contraddizioni e di parole che fanno a pugni con la logica. Soltanto un giornalista chiede ai due procuratori spiegazioni sul setto nasale deviato. La risposta fu: “Qui entriamo nella leggenda”. Abbiamo visto tutti le foto che mostrano il cadavere di Attilio». Foto scioccanti di un corpo martoriato, riverso in una pozza di sangue e proiettate pochi minuti prima che iniziasse la presentazione del libro, affinché anche i numerosissimi presenti potessero giudicare se si tratti di leggenda oppure no. Impossibile non accorgersi dell’assoluta incongruenza di queste indagini. «Il dato principale, e che per me – continua Lo Bianco – resta il dato principale, è che la morte per droga di Attilio si fonda su un dato di fatto inesistente e cioè una perizia tricologica dalla quale si evincerebbe che Attilio era un consumatore abituale di stupefacenti. Ebbene, questo esame agli atti della Procura di Viterbo non c’è. È presente soltanto un appunto sanitario fatto nell’immediatezza dell’episodio, dal quale si evincerebbe che, forse, dall’esame superficiale di un capello ci potevano essere delle tracce. Ma non c’è una perizia, né una consulenza. Si tratta quindi di una prova sostanzialmente inesistente sulla quale si è costruito l’intero castello di accuse». Il cronista ne è convinto: la vicenda di questo giovane e brillante urologo si inquadra nel più ampio contesto che conduce di fatto alla trattativa Stato-mafia. «Trattativa che, se non processualmente almeno logicamente, arriva anche al periodo del favoreggiamento della latitanza di Bernardo Provenzano, che secondo me è uno dei protagonisti “terminali” di quel periodo della trattativa. E proprio perché si inquadra lì, questo libro l’avrei intitolato Un “suicidio” di mafia-Stato. Dobbiamo cominciare a dare un nome più preciso alle cose».
Che la “misteriosa” morte di Manca sia avvolta da un indicibile “segreto di Stato”, ne è convinto anche Saverio Lodato. «Ho visto anch’io quelle foto e credo che qualunque pubblico ministero che avesse indagato dieci anni fa sulla segnalazione della presenza di Provenzano a Marsiglia per farsi operare alla prostata, e se fossi convinto da pubblico ministero di avere condotto indagini minuziose e scrupolose, che certificavano la data di arrivo e di partenza di Provenzano, con i nomi e i cognomi dei suoi fiancheggiatori, dei parenti che con ogni probabilità gli erano andati a fare visita, dei documenti falsi che gli aveva messo a disposizione il presidente del Consiglio comunale di un paese del Palermitano; ecco, se io mi fossi convinto di tutto questo, vedendo le foto di Attilio Manca, mi interrogherei sul fatto che forse qualcuno volle farmi credere lucciole per lanterne. E allora io credo che a distanza di anni, se io fossi quel pubblico ministero, non teorizzerei più la bontà di quell’indagine, ma diventerei parte in causa per chiedere oggi, dieci anni dopo, che quelle indagini venissero riaperte». Cosa viene in nostro aiuto per capire quando non ci troviamo di fronte ad un suicidio, ma di un omicidio che ha che vedere con “i poteri forti” del nostro Paese? Quando si registrano i depistaggi. «Con un’ottima approssimazione possiamo affermare che se c’è depistaggio, lì c’è lo zampino dello Stato. E ho l’impressione che nella morte di Attilio Manca di depistaggi ce ne siano stati e continuano ad esserci anche oggi». E in effetti, come ha ricordato il giornalista Lorenzo Baldo, che ha moderato l’incontro, «uno dei depistaggi più eclatanti in questa storia è fatto da un uomo di Stato: Salvatore Gava, ex capo della Squadra mobile di Viterbo, condannato tra l’altro dalla Cassazione per aver falsificato i verbali sui fatti accaduti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. Dopo il decesso del medico siciliano, Gava scrisse che nel periodo di degenza di Provenzano a Marsiglia, Attilio Manca non si sarebbe mosso dall’ospedale Belcolle di Viterbo dove prestava servizio. L’ex poliziotto è stato smentito da una recente ricostruzione effettuata dalla trasmissione Chi l’ha visto?. Proprio nei giorni in cui Provenzano era sotto i ferri in terra francese, il dottor Manca era assente dall’ospedale. Quindi perché un capo della Squadra mobile falsifica e depista le indagini? E perché entra Provenzano in questa storia? Altro dato oggettivo è l’intercettazione del mafioso Pastoia, nell’ambito dell’operazione “Grande mandamento” del 2005. Tre giorni dopo aver detto che Provenzano era stato operato e assistito da un urologo siciliano, si suicida nella sua cella». Mettendo insieme i pezzi, si capisce che attorno alla morte di Attilio Manca c’è un mistero molto più profondo di quello che appare. Un’altra intercettazione, questa volta del 2007, di Vincenza Bisognano (moglie e sorella di boss della mafia barcellonese, oggi “pentiti”) mentre si trova in auto con altre persone e parla proprio di Provenzano e della morte di Attilio Manca. Un amico della donna dice: «Ma questo ragazzo era a Roma. Chi doveva dargli fastidio?». La Bisignano risponde: «Perché lui l’aveva riconosciuto», e per tutta risposta sempre la stessa persona controbatte: «Ma lo sapevano persino le panchine del parco, che Provenzano, quando era latitante, si trovava a Portorosa». «Ecco – continua Baldo – mettiamo insieme i pezzi e capiamo subito che su questa vicenda c’è un’ombra mafiosa forte, c’è la presenza del capo dei capi di Cosa nostra».
Ma è soprattutto «una vicenda giudiziaria paradossale», come evidenzia Antonio Ingroia, legale della famiglia Manca insieme all’avvocato Fabio Repici, che, in merito proprio all’incartamento processuale delle mancate indagini della Procura di Viterbo, ebbe sin dall’inizio forti dubbi. «Dubbi che divennero presto certezze e certezza che oggi si è trasformata in vera e propria indignazione. Un’indignazione crescente ogni volta che metto piede in quel Palazzo di Giustizia». L’ex pm di Palermo ricorda come in tanti anni di carriera si sia imbattuto diverse volte in carte che mostravano una chiara mediocrità professionale, che forse mascheravano qualcos’altro. «Devo dire, però, che non avevo mai visto un fascicolo con una sciatteria investigativa di questo livello e contemporaneamente un’arroganza manifestata dai magistrati che hanno archiviato queste indagini». E poi ancora quelle foto, che non necessitano chissà quale intuizione investigativa. «Non sono le foto né di un suicidio, né di un’overdose accidentale. Sono chiaramente indicative di un omicidio a seguito di un violento pestaggio». Non rimane che appigliarsi a quell’unico spiraglio, che nasce da «un processetto» con il quale «la Procura di Viterbo tenta di salvare la faccia (ma non la salva), cercando di mandare a processo la presunta spacciatrice che avrebbe ceduto la dose letale ad Attilio Manca. Ciononostante, siccome è l’unico spiraglio che uno Stato ingiusto consente alla famiglia per fare chiarezza, cercheremo davanti ad un giudice terzo di svolgere alcuni degli accertamenti che non sono mai stati eseguiti con la volontà di accertare la Verità, ma di trovare una conferma di una verità pregiudizialmente assurta. Una verità non caduta dal cielo, ma frutto di depistaggi costruiti a tavolino». Vengono alla mente gli omicidi di Mauro Rostagno e di Peppino Impastato, attorno ai quali per anni qualcuno ha tentato di far emergere una verità altra, nonostante l’impegno di alcuni magistrati, sempre troppo pochi rispetto ai colleghi che sembrano voler remare contro l’affermazione di Verità e Giustizia nel nostro Paese. «C’è purtroppo anche una magistratura che insabbia e il volto invisibile di uno Stato spesso nemico di certe verità e di una giustizia che vuole andare avanti senza guardare in faccia a nessuno. Ed è questo quello che pesa più di tutto».
È chiaro che i collegamenti tra la morte di Attilio Manca e Provenzano non possono essere soltanto delle suggestioni e, se ancora non si è giunti alla verità, la colpa non può essere attribuita ad una mera pigrizia o mediocrità investigativa. Il depistaggio delle indagini c’è stato e la storia ci insegna che quando ciò avviene è perché lo Stato vuole salvare se stesso, non certo la mafia.
«Il ruolo di Provenzano nella morte dell’urologo va inserito in un’ottica sempre più plausibile, se non probabile, della volontà di un omicidio finalizzato ad eliminare un testimone scomodo», afferma il giudice Nino Di Matteo. «Per esplorare e capire vicende come questa, è necessario indagare e conoscere contesti più ampi. È necessario allargare lo sguardo, volare alto, senza dimenticare quello che deve essere il rigore e la concretezza dell’approccio investigativo. Bisogna affidare questo criterio ad una scena più grande e diversa da quella terribile che si presentò agli occhi del caposala Fabio Riccardi del Belcolle di Viterbo quella mattina del 12 febbraio 2004. […] È da quei tragici fotogrammi, da quel volto tumefatto, da quel setto nasale che non è semplicemente deviato ma distrutto, e da quei segni chiari di violenza, che prende le mosse l’inchiesta giornalistica – completa e rigorosa – di Luciano Mirone, in cui i fatti vengono snocciolati, analiticamente ricostruiti, ma sempre nella loro rappresentazione scritta e tenuti separati da deduzioni e convincimenti. Fatti che seguono semplicemente il percorso della logica, del buon senso, dell’onestà intellettuale e del coraggio di chi non vuole acriticamente accettare le verità ufficiali, più comode e meno scabrose». È proprio in virtù di questo, oltre che per la stima della dignità con la quale la famiglia Manca affronta il dolore davanti alle meschine opere di delegittimazione post mortem, che il dottor Di Matteo ha accettato di intervenire al dibattito; «per il desiderio di rendere merito a quel tipo di giornalismo di cui tutti, e in particolare la magistratura, sentiamo il bisogno, proprio nella misura in cui quel tipo di giornalismo costituisce l’antidoto più efficace per la magistratura onesta e coraggiosa contro quella magistratura che vuole archiviare per sempre nel dimenticatoio pagine ancora oscure della nostra storia recente, che, se rimarranno tali, perpetueranno all’infinito la forza di ricatto della mafia e dei poteri deviati rispetto allo Stato, quello vero, quello che non ha paura di far emergere responsabilità di suoi rappresentanti, quello che non accetta di nascondere la polvere sotto il tappeto e che non si rassegna al trionfo di non dichiarate e perciò inconfessabili ragioni di Stato, che impediscono od ostacolano l’emergenza della verità». Mettere insieme i fatti, contestualizzarli, esaminarli analiticamente ma in collegamento reciproco: è questo il merito riconosciuto all’opera di Mirone dal pm di punta dell’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia in corso davanti alla Corte d’assise di Palermo. «Non possiamo stare in silenzio di fronte al composto dolore dei familiari e ai troppi dubbi sulla ricostruzione ufficiale della Procura e del Gip di Viterbo. Sono tante le anomalie, ma bisogna osservare lo scenario completo in cui si inserisce questa storia, che riguarda il contesto barcellonese sin dai primi anni ’80. Un contesto che vede Barcellona Pozzo di Gotto come coacervo di interessi di personaggi contemporaneamente legati alla mafia, a logge massoniche e ad ambienti della destra eversiva. Un contesto territoriale da questo punto di vista assolutamente unico, come assolutamente significative sono le acquisizioni probatorie che noi abbiamo su certi personaggi barcellonesi, che in sé accorpano queste caratteristiche. Non a caso Barcellona è il luogo dal quale viene fornito il telecomando utilizzato da Giovanni Brusca per azionare l’esplosivo a Capaci il 23 maggio del ’92. Non a caso Barcellona è il luogo dove per anni, e proprio nel periodo antecedente le stragi del ’93, era latitante Nitto Santapaola. È qui che, il 5 aprile 1993, il boss viene registrato da intercettazioni ambientali dei carabinieri del Ros. Il giorno dopo una sparatoria a Terme Vigliatore, a 4 km di distanza dal luogo in cui era stata registrata la voce di Nitto Santapaola, coinvolge alcuni ufficiali del Ros e tale Imbesi Fortunato. Non sto dicendo nulla di nuovo, non sto parlando di indagini. Tutto questo è scritto in atti processuali pubblici e che è frutto anche delle testimonianze rese dagli investigatori in aule di giustizia, ma che probabilmente dalle aule di giustizia queste cose non escono o non vengono rappresentate adeguatamente da un’informazione sempre sospettosamente distratta su queste vicende». E ancora: «Barcellona è il teatro del protagonismo di Rosario Pio Cattafi e di un’ulteriore e importante passaggio della trattativa Stato-mafia che, stando alle dichiarazioni dello stesso Cattafi, riguarda proprio il tentativo di ottenere da Santapaola un atteggiamento più morbido della mafia e in particolare della cessazione della strategia stragista, evidentemente in cambio dell’adempimento di alcune promesse da parte dello Stato. E allora – conclude il magistrato – se tutto questo è Barcellona, e se gran parte di questo ha ruotato intorno alla figura di Bernardo Provenzano e ai suoi rapporti nascosti e mai dichiarati con pezzi dello Stato, è aprendo lo scenario che noi possiamo capire perché è morto Attilio Manca. Non possiamo accettare che non confessate ragioni di Stato impediscano l’accertamento della verità e rendano vani gli sforzi di tutti coloro che lottano per la verità e la giustizia, a partire dai familiari delle vittime di mafia».
Anche il direttore di ANTIMAFIADuemila, Giorgio Bongiovanni, non ha dubbi circa il coinvolgimento di personaggi non mafiosi nello “strano caso” della morte di Attilio Manca. «Il movente più vero e pericoloso per il quale il medico siciliano doveva essere ucciso, non è quello relativo al timore che Provenzano potesse essere catturato grazie alla sua testimonianza, ma che lui potesse indicare, oltre al volto del boss e quello dei suoi complici mafiosi, anche quello di personaggi dello Stato che proteggevano Provenzano. Nel momento in cui quei personaggi si resero conto che un dottore di quel livello, estremamente attendibile, avrebbe potuto indicare una faccia che appartiene allo Stato, compromettendo la storia della nostra Repubblica con un eventuale indagine e relativo processo su uomini di Stato che proteggevano Provenzano, Attilio fu eliminato. Il delitto di Attilio Manca è un omicidio di Stato, ne sono convinto, compiuto per coprire certi personaggi che in quel momento dovevano proteggere il boss, in quanto garante della trattativa. È lo stesso Stato che per 23 anni aveva protetto anche Riina, è lo stesso Stato che è stato co-partecipe, se non organizzatore, delle stragi di Capaci e via D’Amelio».
Ultimo a prendere la parola all’evento al quale hanno partecipato decine e decine di cittadini assetati di verità, è stato Gianluca Manca, fratello di Attilio. «Desidero ringraziare ancora una volta Luciano Mirone, perché anche grazie a questo libro non è più soltanto la famiglia Manca ad urlare contro la Luna. Non abbiamo mai creduto alla tesi del suicidio, ma lottato perché si andassero a cercare le due principali motivazioni che devono far comprendere che si trattò di omicidio: l’appartenenza territoriale di Attilio e la sua professione. Adesso c’è anche un magistrato autorevole della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, come il dottor Di Matteo, a fare un nome per tutti. Un nome che a Barcellona Pozzo di Gotto è molto conosciuto: l’avvocato Rosario Pio Cattafi. Sono dieci anni che noi non facciamo altro che citare questo nome in ogni conferenza, paragonandolo non all’appartenenza della blanda manovalanza mafiosa, ma ritenendolo l’anello di congiunzione tra Cosa nostra, i Servizi deviati e la massoneria». Innegabile che Barcellona sia “cresciuta” dopo la morte di Attilio Manca. Lo afferma anche il procuratore capo di Messina Guido Lo Forte, che ha posto un parallelismo tra Palermo e Messina, un tempo quest’ultima definita la provincia babba (stupida) della Sicilia, ma che ormai suona come un appellativo certamente non corrispondente al vero, che forse, addirittura, ha contribuito a generare in taluni personaggi quello scatto d’orgoglio mafioso, tale da far sì che oggi abbia raggiunto per “meriti” il capoluogo. Un livello conquistato offrendo, come si è detto in premessa di questo articolo, il migliore urologo in circolazione a Bernardo Provenzano, da usare come merce di scambio per gli interessi economici, politici, imprenditoriali e istituzionali di Barcellona Pozzo di Gotto. «Non sono sicuramente, queste, le fantasie della famiglia Manca, ma sono dei pensieri maturati in seguito alla ricostruzione che abbiamo fatto dell’ultimo anno di vita di Attilio, come dei suoi spostamenti, in particolare di quel viaggio a Marsiglia. […] La Procura di Viterbo ci deve spiegare perché per dieci anni hanno dato per vera la relazione del commissario Gava e perché l’esame tricologico non fosse mai stato effettuato. Noi abbiamo sempre creduto nella giustizia e abbiamo creduto anche che un commissario relazionasse una verità giuridica e invece avremmo dovuto volare alto; perché una trasmissione televisiva è riuscita ad accertare che in realtà Attilio, negli stessi giorni relazionati dal dottor Gava, non si trovava nell’ospedale Belcolle di Viterbo dove effettuava la sua professione di urologo, ma non sappiamo dove. Evidentemente a Viterbo è accaduto e sta ancora accadendo qualcosa di marcio, perché quella relazione autentica non è. Ci devono spiegare perché per dieci anni ci hanno mentito. Vedete, noi non alziamo la voce semplicemente come familiari di Attilio Manca, ma soprattutto come cittadini italiani che vengono presi in giro da una Procura della Repubblica».
E ognuno di noi ha il dovere morale di difendere la memoria di Attilio, pretendendo di avere le risposte alle tante domande che, in maniera del tutto lecita e legittima, ci poniamo da troppo tempo. Nonostante questo, nonostante siano già passati dieci lunghi anni e qualcuno tenti ancora maldestramente ma senza alcuna vergogna di ostacolare il raggiungimento della verità e della giustizia, non ci stancheremo mai di porle, fino a quando quelle maledette risposte non ci verranno date.
Tratto da: antimafiaduemila.com
Foto © Agnese Monasteri

La misteriosa morte di Attilio Manca, che tutto sembra meno che un suicidio
- Dettagli
- Articoli 2014